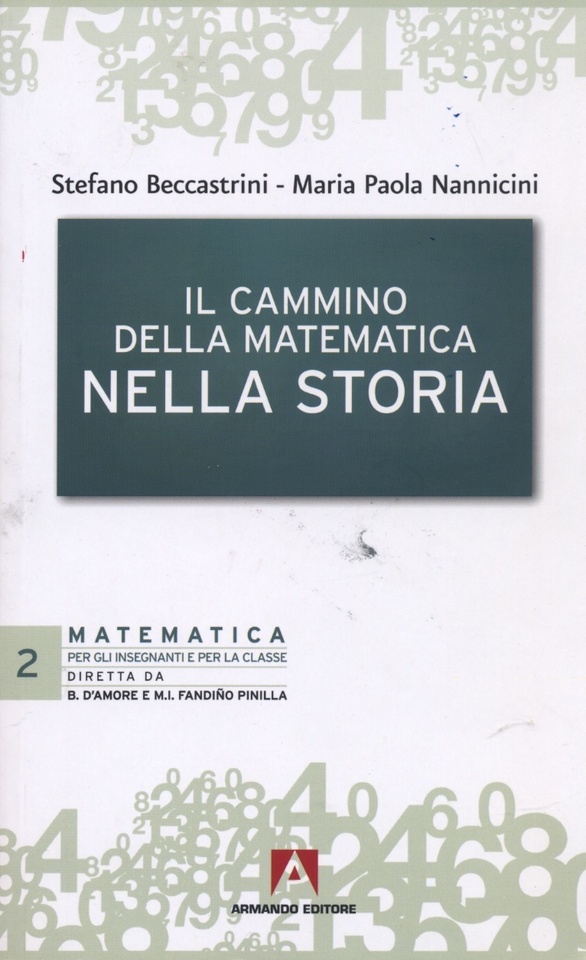In uno scritto di qualche tempo fa sul tema delle tecnologie nell’insegnamento universitario raccontavo come io veda due diverse università: quella della routine quotidiana e quella criticata o immaginata da coloro che si pongono il problema del suo ruolo nella società presente e soprattutto futura.
Per non contare solamente sulle mie impressioni personali avevo citato le opinioni di alcuni personaggi di fama internazionale, selezionandone tre fra tanti: Sir Ken Robinson, professore emerito alla università di Warwick, Don Tapscott, esperto di strategie di business e di IT di fama internazionale, giornalista, autore di vari bestseller e Daniel Lemire, professore di computer science alla università di Quebec e Montreal.
Le opinioni di personalità di questo calibro, due professori e un “osservatore” esterno all’università, dovrebbero essere sufficienti a sollevare l’attenzione sul ruolo delle università nella società della conoscenza.
Mi rimane tuttavia la sensazione che occorra chiarire ulteriormente le motivazioni della cogenza del problema. I tre personaggi che ho citato fanno parte di coloro che guardano avanti, di coloro che vengono usualmente definiti progressisti.
Sono persone che dicono: il contesto sociale, economico e tecnologico sta mutando rapidamente, l’accademia sta mostrando di non farcela ad adattarsi, bisogna quindi darsi da fare per inventare qualcosa di nuovo, anche di radicalmente nuovo, se necessario.
È inevitabile – è sempre successo – che a questa visione se ne contrapponga un’altra: è vero, il contesto sta mutando e occorre tenerne conto ma ha avuto anche luogo una degenerazione dei costumi – giovani superficiali, distratti e impreparati – e una decadenza di una qualità che invece un tempo l’accademia esprimeva.
Per chiarire la questione, formulo la seguente tesi che cercherò di sostenere con alcuni riferimenti raccolti in un passato insospettabile:
- il sistema di istruzione è sempre stato ampiamente subottimale, non è vero che l’università di una volta era un’altra cosa, semplicemente si collocava in una società un po’ meno complessa e interconnessa di ora e, soprattutto, doveva affrontare una massa molto più ridotta;
- la risposta alle crescenti necessità di una società sempre più articolata e dinamica da parte dell’università è stata sostanzialmente di natura burocratica e solo marginalmente culturale.
Con risposta di natura burocratica intendo dire che, per esempio,
- il problema dell’esplosione delle conoscenze è stato affrontato semplicemente ingrassando le facoltà di lauree, le lauree di insegnamenti e gli insegnamenti di argomenti;
- il problema della massa è stato affrontato preoccupandosi dell’efficienza ma non dell’efficacia, preoccupandosi cioè di affrontare le masse crescenti di studenti con il modello convenzionale, semplicemente organizzando classi sempre più numerose, sino ad arrivare alla norma del centinaio o più di studenti per classe, senza molta attenzione al risultato effettivo in termini di apprendimento;
- l’università si è occupata quasi esclusivamente di conoscenza esplicita, facilmente codificabile e gestibile, ma non di conoscenza tacita.
 Richard Sennet (P. 81) scrive a proposito della trasmissione del sapere nelle botteghe artigiane dal rinascimento in poi:
Richard Sennet (P. 81) scrive a proposito della trasmissione del sapere nelle botteghe artigiane dal rinascimento in poi:
… in un laboratorio dove domina l’individualità e l’originalità del maestro, tenderà a essere predominante anche il sapere tacito. Morto il maestro, non è più possibile ricostruire gli indizi, i gesti e le intuizioni che egli aveva raccolto e coordinato in quel tutto unico che è l’opera; non possiamo più chiedergli di rendere esplicito quel sapere tacito.
In teoria, in un laboratorio ben diretto dovrebbe esserci equilibrio tra sapere tacito ed esplicito. Si dovrebbe insistere con forza perché i maestri si spieghino meglio, perché ripeschino quel mosaico di indizi e di gesti che hannno assorbito dentro di sé in silenzio … ammesso che ne siano capaci, e ammesso che lo vogliano. La loro stessa autorità deriva in gran parte dal fatto di vedere ciò che altri non vedono, di sapere ciò che altri non sanno; la loro autorità si rende manifesta nel loro silenzio.
Può sembrare limitativo citare le botteghe artigiane riferendosi alla trasmissione delle conoscenze nell’accademia. Certamente i due tipi di saperi sono diversi ma tale diversità anziché distinguere positivamente la conoscenza accademica rappresenta un qualcosa che invece è stato perso.
Con la migrazione delle prime macchine dai laboratori artigiani alle industrie si attua il movimento dal sapere pratico all’autorità dominante del sapere esplicito. Il sapere esplicito è quello che forma la conoscenza teorica, espressa in modo proposizionale, che è quella che con larghissima prevalenza trasmette l’università.
La trasmissione della conoscenza è così divenuta una questione di trasmissione dei “contenuti”, tutti teorici. Tale forma monca di conoscenza è, sì, molto adatta alla costruzione di un sistema di controllo basato sull’autorità di chi è accreditato alla generazione, detenzione e trasmissione della conoscenza ma fallisce sostanzialmente nell’obiettivo di preparare effettivamente gli studenti.
Mi sto qui riferendo all’università ma il male è comune a tutta la scuola, specialmente quella secondaria. È fin troppo facile citare il fallimento dell’insegnamento dell’inglese e della matematica, due ambiti nei quali i risultati si manifestano in modo immediato e impietoso.
Questa grave carenza, che deriva da un malinteso concetto di conoscenza, non ha niente a che vedere con un processo di degenerazione recente della scuola. Personaggi avveduti e di prestigio hanno espresso disagio ben prima di tali presunti fenomeni di degenerazione.
Carlo Columba nel suo blog pone una questione che riprende da uno straordinario articolo (pdf) del prof. Enrico Persico, collaboratore di Enrico Fermi, apparso sul Giornale di Fisica del 1956. Il prof. Persico racconta di come una brava studentessa all’esame “corra come una locomotiva” nella trattazione formale delle equazioni di Maxwell ma riveli un totale disorientamento in qualsiasi aspetto pratico della materia, sino ad avere imbarazzo addirittura a descrivere uno strumento o una situazione sperimentale con un disegno:
Vi è poi una inesplicabile difficoltà a descrivere anche il più semplice oggetto o fenomeno, sia con la parola, sia, ancor più, col disegno. Il disegno (schematico beninteso) che sembrerebbe in molti casi un mezzo spontaneo, quasi quanto il gesto, per aiutare la parola ad esprimere ciò che si ha in mente, non viene per lo più nemmeno preso in considerazione dall’esaminando, e ogni invito a servirsene viene considerato come un crudele aggravamento di pena. Si ha l’impressione che il candidato non abbia un’immagine mentale da tradurre in parole o in linee, ma piuttosto da ripetere un discorso quanto più fedelmente è possibile. E ciò che è più strano è che la maggior parte degli studenti considera facile la parte descrittiva del corso, e difficile invece la parte matematica.
Mi sovviene in proposito il mio esame di Fisica Generale I, considerato a quei tempi (1974) lo scoglio fondamentale del corso di laurea in Fisica a Firenze, Arcetri per la precisione. La prima domanda che il professore Manlio Mandò mi fece fu: “Disegna un cannone …” E su quel cannone e i proiettili che questo sparava ragionammo per più di due ore, le mie mani, e forse anche il cervello, completamente impastate di gesso e sudore.
Le leggende su quell’esame si sprecavano. Si narrava di ottimi studenti che l’avevano dovuto ripetere cinque o sei volte. Di interrogazioni durate ore che continuavano il giorno dopo. Io stesso ho udito un professore più giovane, a sua volta dei più severi, che raccontava di avere tribolato molti mesi sull’esame del prof. Mandò. Noi calcolavamo di dovergli dedicare almeno sei mesi, al di là delle lezioni, se tutto andava bene.
Ma in quell’esame, iniziato col disegno di un cannone, non dovetti recitare niente bensì mi furono posti solo problemi e per rispondere potevo solo pensare, c’era ben poco da ricordare. Quell’insegnamento era infatti basato sull’esercizio del pensiero. Per superare l’esame era perfettamente inutile imparare il libro a memoria, cosa che sarebbe stata anche relativamente facile perché conteneva pochi argomenti; era invece necessario fare centinaia di esercizi e veniva infine spontaneo ritrovarsi con i compagni di corso per aiutarsi a vicenda nella soluzione degli esercizi più difficili.
Ecco di cosa si lamentava il prof. Mandò nella “Premessa per lo studente” delle sue “Lezioni di Fisica Generale” (Libreria Universitaria di Bologna, quarta edizione del 1968)”

- la scarsa preparazione matematica posseduta dalla generalità degli studenti;
- l’eterogeneità della stessa preparazione generale, che va dall’astratto filosofeggiare dei provenienti dal Liceo Classico al particolarismo tecnico dei provenienti dall’Istituto Tecnico;
- l’eccessivo affollamento delle classi, che si avvicinano sempre più al fatidico numero di 250 studenti, oltre il quale anche le vigenti disposizioni riconoscono impossibile lo impippiamento di una disciplina universitaria da parte di un solo professore.
Continuava poi:
Date queste premesse, il meglio che si possa fare è quello di basare il corso sulla limitazione del numero degli argomenti e sull’appronfondimento di ognuno di essi, dando ovviamente la preminenza ai principi generali rispetto ai fenomeni particolari, la cui conoscenza è pur sempre necessaria ma potrà essere più facilmente acquisita dallo studente direttamente, anche senza l’ausilio di apposite lezioni.
Successivamente (pag. 8 punto d), poneva l’enfasi sul ruolo fondamentale
dell’iniziativa individuale nello studio, perché le lezioni stesse non bastano, tanto che Oppenheimer parlò addirittura del mostruoso anacronismo di cercare di istruire facendo lezione (“to educate by lecturing”).
Ancora successivamente (pag. 9) ci spiega come
la Fisica non la si insegna, ma si può solo aiutare ad apprenderla, così come non si insegna ad andare in bicicletta. L’insegnante, per così dire, potrà solo, tenendovi per il sellino, evitare i primi, più grossi, capitomboli, potrà indicarvi la progressione più ragionevole nei vostri tentativi di equilibrio, segnarvi la meta, consigliarvi la via: il resto dovete farlo voi.
Ricapitoliamo. L’esame del prof. Mandò rappresentava un ostacolo micidiale in uno dei corsi di laurea ritenuti più difficili e selettivi. Le parole che abbiamo letto sono state scritte nella quarta edizione del 1968, quindi le lamentazioni del prof. Mandò si riferiscono ad un’epoca precedente al ’68, a scanso di equivoci.
Orbene, da quei remoti tempi la voce di un severo professore “all’antica” ci ammonisce sulla inutilità di addensare argomenti in un insegnamento e sull’opportunità di concentrarsi nell’esercizio del pensiero sui principi, ritenendo così che lo studente volenteroso potrà successivamente volare con le proprie ali sulle altre regioni della materia, e non solo aggiungo io.
Ci ammonisce sull’inutilità di fare solo lezioni, richiamandosi ad un’assai drastica affermazione di un grande scienziato; in particolare sull’inutilità di lezioni fatte con rapporto studenti docenti troppo alto. Nel libro di esercizi che accompagna le “Lezioni di Fisica Generale” raccomanda addirittura lezioni in gruppi di non più di 30 alla volta, sotto la guida di un adeguato numero di insegnanti! Inoltre esprime con le parole di allora un ruolo dell’insegnante che oggi viene designato come facilitatore: non colui che insegna ma colui che aiuta ad apprendere.
Io credo che il corso del prof. Mandò sia uno dei pochi nei quali ho imparato qualcosa di importante: non tanto la fisica quanto il pensiero fisico. Questo è l’equivoco fondamentale dell’insegnamento di quasi tutte le discipline in quasi tutte le scuole (università compresa). Si può prendere una laurea in fisica o in matematica, come in qualsiasi altra disciplina, senza in realtà avere interiorizzato il pensiero fisico, il pensiero matematico ecc. Quello che rende un fisico (o un matematico o altro) tale è il modo di vedere il mondo, la prospettiva sotto la quale vede le cose, non il fatto che sappia un certo numero di fatti, è ovvio che finisca col saperli ma è conseguente. Se poi un fisico che è tale in questo senso (o matematico o altro) riesce a percepire anche le altre prospettive e a metterle in relazione con la propria, diciamo con la “prospettiva madre” come la lingua madre, allora si può iniziare a parlare di cultura. Prima no.
Il prof. Persico si rammaricava di non vedere nascere pensiero fisico nei suoi studenti e il prof. Mandò si preoccupava di vedere nascere il pensiero fisico nei propri. Faceva questo con lunghe appassionate lezioni che integrava come poteva, con domande, stimoli, esercizi a non finire, disponibilità a rispondere e commentare qualsiasi domanda, esami che non finivano mai …
L’intento del professore si traduceva anche in un passaggio di conoscenza tacita, malgrado l’eccessiva numerosità della classe – eravamo già oltre cento. Il suo desiderio, espresso esplicitamente, di poter lavorare con non più di trenta studenti per volta, riconduce all’atmosfera descritta da Sennet nel laboratorio artigiano del passato dove il giovane apprendista-artista veniva in contatto sia con la conoscenza esplicita che con quella implicita, emanata dall’agire del maestro, d’entrambe nutrendo la sua propria crescita.
Sennet con la sua analisi dell’uomo aritigiano evidenzia magnificamente quanto sia stata controproducente la separazione della testa dalla mano. E non si deve pensare che il ragionare di fisica, come di qualsiasi altra disciplina, anche di filosofia, sia tanto diverso dal lavoro dell’artigiano. Fare fisica vuol dire cimentarsi con le idee, giocare con le idee, e non solo riceverle. Apprendere non è prendere atto ma rivivere. Fare l’artigiano con una teoria fisica vuol dire domandarsi che succede se si cambia un’ipotesi, che succede se cambia una condizione al contorno, perché un fatto ci sembra parente di un altro anche se non ce l’ha detto nessuno e così via. Maestro e discepolo giocano insieme su queste domande.
 Nell’aprile del 2008 abbiamo respirato la medesima atmosfera in un bellissimo intervento (pdf) fatto nella classe di medicina dal prof. Benedetto De Bernard, figura di spicco della biochimica italiana.
Nell’aprile del 2008 abbiamo respirato la medesima atmosfera in un bellissimo intervento (pdf) fatto nella classe di medicina dal prof. Benedetto De Bernard, figura di spicco della biochimica italiana.
Il prof. De Bernard si poneva la domanda:
Chi deve dunque insegnare?
La mia risposta è: chi “ha la testa ben fatta” (Morin). Questa si differenzia dalla “testa ben piena”, nella quale come dice Morin, il sapere è accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione.
“Una testa ben fatta significa che invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso tempo di:
- un’attitudine generale a porre e a trattare problemi;
- principi organizzativi che permettano di collegare le cognizioni e dare loro senso”
Successivamente, il prof. De Bernard approfondiva il tema sostenendo:
Il risultato dell’apprendimento dipende, secondo me, dalla intensità emozionale dell’incontro docente-discente.
Costui deve sentirsi affascinato dal docente, che deve essere quindi capace di trascinare i suoi allievi: costoro, subendone il fascino, ameranno i concetti scientifici trasmessi e li ricorderanno per tutta la vita.
Il modo di essere del docente, il calore delle sue convinzioni, persino la sua gestualità sono più utili di ogni modello di insegnamento, che gli studi della didattica medica vannno proponendo. Cioè il docente è libero di scegliere il modello che preferisce e che gli è più congegnale, persino la lezione ex-cathedra, accanto a lezione-discussione del tipo seminariale o tutoriale, il tutto basato sia su “active-learning” che su “problem base learning”.
Ecco, “persino la lezione ex-cathedra” e non sempre e solo lezione ex-cathedra.
Nella discussione finale, De Bernard, stimolato dalle domande precisò che in generale nella pratica didattica, il numero di lezioni frontali è esagerato e che andrebbe drasticamente ridotto a favore di ogni tipo di attività e di discussione possibile, seminariale, di laboratorio o altro.
Ritorna così l’idea di Sennet, dove un vero rapporto di insegnamento non può prescindere da una sorta di osmosi fra l’insegnante e i suoi studenti che garantisca non solo la trasmissione di sapere esplicito ma anche di sapere tacito.
Orbene, i riferimenti che ho portato in queste righe sono tutti riconducibili a uomini molto anziani o del passato, che hanno vissuto e operato all’interno dell’accademia, scienziati e insegnanti severi. Tuttavia sono uomini che hanno volto lo sguardo in una direzione che il sistema universitario non ha neanche lontanamente provato a seguire. Piuttosto, la strada che tale sistema ha seguito è quella di un amministratore poco avveduto e direi, quasi, poco esperto.
Ora, che i problemi di volume, sia in termini di popolazione studentesca che di conoscenze, e di dinamicità, sia in termini di richieste del mondo del lavoro che di sviluppo delle conoscenze, fanno scricchiolare pericolosamente il sistema universitario, gli accademici e gli osservatori esterni “progressisti” ne paventano la fine, almeno in questa forma.
È qui che ha senso ricorrere alle tecnologie ma non per vestire con abiti giovanili un corpo ormai vecchio bensì per ricondurre i maestri e gli allievi nel laboratorio artigiano.